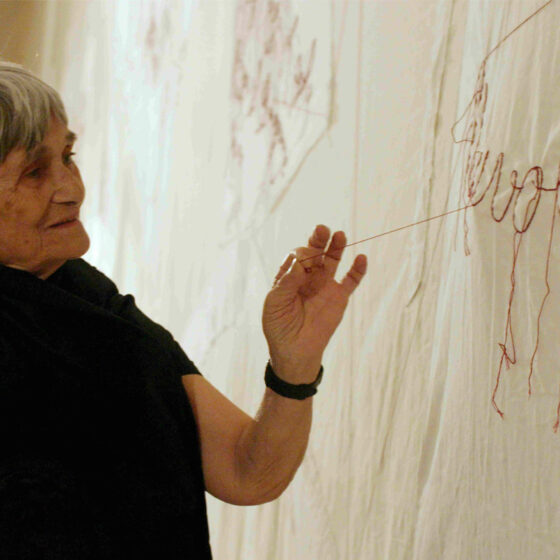Le parole dello scrittore e docente siciliano che è stato tra i protagonisti dell’edizione 2022 del Premio Costa Smeralda
Lo scorso anno è stato uno dei protagonisti del Premio Costa Smeralda, uno dei primi eventi culturali della stagione smeraldina. L’autore (in passato è stato docente di Colture arboree all’Università di Palermo) ha ricevuto in quell’occasione una menzione speciale assegnata per il suo contributo prezioso nella cultura e nella letteratura contemporanea. I frutti del suo lavoro si vedono a occhio nudo. Volumi che dimostrano non solo l’importanza di uno sguardo critico quando si tratta di sviluppare un pensiero logico, ma anche la possibilità di servirsi dei concetti assimilati per guardare il mondo con una nuova prospettiva. L’ambiente e il territorio restano un punto fermo anche in “Agrumi. Una storia del mondo” (edito da Il saggiatore). Un viaggio ricco di dettagli che si focalizza sulla storia degli agrumi e sul legame che si è creato con l’uomo.

Il suo ultimo libro racconta le influenze dirette che hanno portato i limoni o i cedri alla storia umana. L’incontro di umanità e agrumi è stato davvero così impattante sullo sviluppo delle civiltà?
«Sì. Ancora oggi gli agrumi, oltre ad avere una certa influenza pensando solo alla vendita della frutta naturale, si trovano in testa alla produzione di succhi e derivati vari. Per non parlare della coltivazione dove conservano ancora il loro primato. Se consideriamo solo l’arancia viene superata soltanto dalla mela nei mercati mondiali. Ma tutto questo non basta a spiegare lo sviluppo degli agrumi nei mercati mondiali riuscendo a raggiungere ogni angolo della terra. La storia in un certo senso ce lo insegna. Che cosa sarebbero infatti i giardini europei se non ci fossero gli agrumi in vaso che vanno e vengono durante l’anno? I primi parterre, le terrazze, le orangerie, le meravigliose serre monumentali presenti in ogni angolo del continente. Se si tornasse indietro nel tempo si troverebbero persino dei riferimenti ai classici miti della civiltà umana, dall’ultima fatica di Ercole oppure la festa dei tabernacoli nella religione ebraica. Una forza simbolica che non si trova in nessun altro albero da frutto».
La nostra società sarebbe ancora capace di modificare il proprio modo di pensare, vivere e curarsi grazie alla scoperta di una nuova tipologia di frutti?
«Gli agrumi insegnano a tenere insieme elementi all’apparenza contrastanti come la dolcezza, l’asprezza, l’acidità. Ma nel libro parlo di due concetti che sono fondamentali: l’utilità e la bellezza. Immaginiamo infatti un pianeta, una terra, un giardino che sia soltanto bello senza essere utile. Con il tempo, in un momento di così grandi cambiamenti, non è più sostenibile. Il paesaggio in questi anni è stato sottoposto a un grande stress, dall’inquinamento, il consumo di suolo agli effetti dei cambiamenti climatici. L’ambiente deve dunque essere, ancora una volta, lo specchio della società in cui viviamo, partendo proprio dall’uso del territorio da parte dell’uomo. Senza mai sacrificare la sua bellezza».
Esistono oggi piante o nuove colture (per esempio la vertical farm) che stanno modificando il nostro modo di coltivare e nutrirci?
«Penso che possano far parte del futuro dell’agricoltura, ma in una dimensione ridotta. Non bisogna scordarsi dei costi di simili strutture, dalla costruzione alla gestione di simili impianti, energia compresa.
Ma ci sono altre differenze con i giardini e la coltivazione tradizionale. La produzione deve infatti tenere ben presente della biodiversità che è fondamentale. La soluzione è in un’agricoltura a cui venga riconosciuta la capacità di offrire quelli che vengono chiamati i servizi ecologici come la bellezza, la cultura, il clima e la difesa del suolo».
Abbiamo imparato dalla storia l’importanza di “accogliere” i benefici provenienti da nuove piante o tutto è diventato marketing e spinta esagerata al consumo?
«Le piante per stessa definizione viaggiano. Non c’è nulla che può infatti fermare il volo di un uccello, il vento che trasporta i semi, i mercanti che viaggiano, gli esploratori in cerca di nuove scoperte. Tutto questo rientra in un processo che coinvolge le diversità biologiche e culturali che sono nel mondo e che, come la storia ci insegna, non possono respingersi. Dove c’è biodiversità c’è complessità, e dove c’è complessità c’è stabilità. Per questo non servono muri, ma ponti che garantiscono questo equilibro inarrestabile».
Riccardo Lo Re